di Marco Belocchi
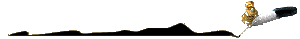
J. era appena morto. Non aveva neanche avuto il tempo di esalare l'ultimo respiro o di guardare dall'alto il suo corpo spento su quel lettino sporco di un ospedale di periferia, che già la sua anima venne risucchiata in un gorgo, proiettata in quella dimensione atemporale che gli antichi chiamavano Ade e che noi impropriamente abbiamo diviso in tre strati, una parte per i buoni, una per i perdonabili e una per i cattivi inveterati. J. si accorse in un milionesimo di secondo che queste zone non esistono, che erano solo frutto di qualche mente deviata che proiettava sulla terra un ideale aldilà.
Si trovò catapultato in un non-luogo, dove qualsiasi riferimento alla dimensione nella quale aveva vissuto per 39 anni era scomparsa. Tuttavia non tutto gli riusciva estraneo, particelle della sua memoria remota avevano subito una leggera scossa e avrebbero potuto entrare in azione, se solo ne avessero avuto il tempo.
Comparvero dinanzi a lui tre forme estremamente mobili, potevano essere fuoco o aria condensata, se questi termini avessero ancora avuto un senso.
Immediatamente gli prospettarono la possibilità di una scelta. Rinascere subito, per esempio, ma azzerando totalmente la memoria, o perlomeno immergerla in uno strato al di fuori della sua percezione. Si aprì uno squarcio e apparvero alcune donne di razze diverse in preda alle doglie che entro qualche minuto, chissà dove e chissà in quale epoca, avrebbero partorito un esserino in cui doveva installarsi la prima anima disponibile.
Oppure tornare nel mondo sotto forma di spettro, con la memoria intatta e l'opportunità di interagire con gli umani, entrare nei loro pensieri, nei loro sogni, forse anche parlare con loro attraverso quei trucchetti che talvolta riescono. Per un attimo J. accarezzò l'idea, ma poi ne percepì la raffinata crudeltà. Non restava che l'ultima. Dissolversi, non esistere più, nemmeno come anima o soffio o essenza. Sparire definitivamente, essere riassorbito in un tutto indistinto.
L'esitazione di J. si concretizzò in un dolore acuto, palpabile, terribilmente umano.
Aprì gli occhi. Delle minuscole luci intermittenti ripresero a pulsare, una donna in lacrime scioglieva sul suo volto un alito caldo e acre. Qualcuno armeggiava frenetico attorno alle macchine. J. era vivo, il suo coma non doveva essere durato molto, qualche ora o qualche giorno, forse. Ha così importanza il tempo, quando la propria anima non è pronta a liberarsi di alcune piccole insignificanti sofferenze? Quando esita?
J. non era semplicemente vivo, era stato condannato a tornare vivo!
Commenta questo racconto
Si trovò catapultato in un non-luogo, dove qualsiasi riferimento alla dimensione nella quale aveva vissuto per 39 anni era scomparsa. Tuttavia non tutto gli riusciva estraneo, particelle della sua memoria remota avevano subito una leggera scossa e avrebbero potuto entrare in azione, se solo ne avessero avuto il tempo.
Comparvero dinanzi a lui tre forme estremamente mobili, potevano essere fuoco o aria condensata, se questi termini avessero ancora avuto un senso.
Immediatamente gli prospettarono la possibilità di una scelta. Rinascere subito, per esempio, ma azzerando totalmente la memoria, o perlomeno immergerla in uno strato al di fuori della sua percezione. Si aprì uno squarcio e apparvero alcune donne di razze diverse in preda alle doglie che entro qualche minuto, chissà dove e chissà in quale epoca, avrebbero partorito un esserino in cui doveva installarsi la prima anima disponibile.
Oppure tornare nel mondo sotto forma di spettro, con la memoria intatta e l'opportunità di interagire con gli umani, entrare nei loro pensieri, nei loro sogni, forse anche parlare con loro attraverso quei trucchetti che talvolta riescono. Per un attimo J. accarezzò l'idea, ma poi ne percepì la raffinata crudeltà. Non restava che l'ultima. Dissolversi, non esistere più, nemmeno come anima o soffio o essenza. Sparire definitivamente, essere riassorbito in un tutto indistinto.
L'esitazione di J. si concretizzò in un dolore acuto, palpabile, terribilmente umano.
Aprì gli occhi. Delle minuscole luci intermittenti ripresero a pulsare, una donna in lacrime scioglieva sul suo volto un alito caldo e acre. Qualcuno armeggiava frenetico attorno alle macchine. J. era vivo, il suo coma non doveva essere durato molto, qualche ora o qualche giorno, forse. Ha così importanza il tempo, quando la propria anima non è pronta a liberarsi di alcune piccole insignificanti sofferenze? Quando esita?
J. non era semplicemente vivo, era stato condannato a tornare vivo!
Commenta questo racconto